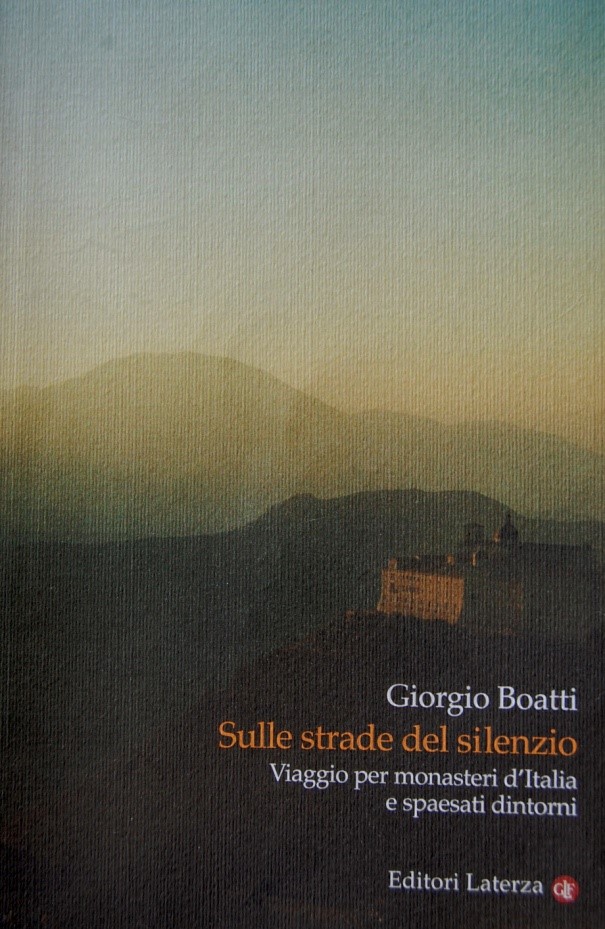
Viaggio per monasteri d’Italia e spaesati dintorni
Editori Laterza, 2012
Alcune volte l’autore di questo godibilissimo libro crede “di aver trovato la strada sbagliata che è giusta per me”. E, forse per questo motivo, non sa se definirsi viandante o pellegrino. Ma la domanda è retorica. Non possono esserci dubbi: Sulle strade del silenzio non è un libro per viandanti, per coloro, cioè, che camminando domandano e domandando scoprono via via nuovi possibili sentieri prima neppure immaginati.
È invece un libro per pellegrini che, come lo stesso Giorgio Boatti ci dice, citando Francesco Cataluccio, “hanno un traguardo sicuro e vanno, seppure con qualche comprensibile esitazione, diritti per il loro percorso.”
Il percorso che l’autore ha scelto è quello per i molti monasteri d’Italia che incrocia tra nord e sud, tra una conferenza e l’altra, nei dintorni di città già visitate, attraverso luoghi già visti di cui conosce strade e alberghi e in cui rincontra amici. Qualche volta scopre anche vie, ambienti e panorami nuovi. E, bellissimo, chiede informazioni appena può a chiunque incrocia perché sente il bisogno di relazionarsi e di capire non solo l’uomo ma anche l’ambiente in cui momentaneamente è immerso.
Boatti è sempre disposto ad allungare i suoi percorsi. E fa, nel rientro, strade diverse di quelle fatte all’andata. Cerca (forse) di perdersi per trasformarsi in viandante. Ma non ci riesce mai: la sua metà è precisa ed è scelta a priori.
Il girovagare continuo gli procura piacere. Il suo tempo non ha bisogno di essere riempito dagli affanni della necessità. Non ha da timbrare cartellini. Non ha fretta. Non ha una casa o familiari da accudire. E nemmeno sembra avere problemi di soldi: può pagare benzina, alberghi, ristoranti anche se girasse all’infinito. Eppure soffre ugualmente. Gli manca qualcosa. E’ disorientato e vorrebbe trovare un solido sostegno a cui aggrapparsi.
“Si fa notte sul bel paese ma il carnevale italiano continua ad essere in corso.” Ci dice malinconicamente.
Il priore di Bose, Enzo Bianchi, lo riassicura. Rievocando i primi anni della sua importante esperienza gli dice “Avevo trovato una ragione per spendere la vita”.
È questo che Boatti cerca? Una ragione per vivere?
Fra abati e semplici monaci, in monasteri sperduti nella natura o in altri circondati dalla frenetica città, fra una storia millenaria e le mille storie di una quotidianità fatta di lavoro e di preghiera, Boatti incrocia il suo tempo libero (e vuoto) con quello di uomini le cui necessità sono ridotte al minimo e, ciò nonostante, hanno ogni minuto della giornata e della vita riempito di azioni sensate.
“Busso a queste porte – ci confessa l’autore – perché ho l’impressione che qui si impari davvero che si può cambiare il mondo, ma – faccenda piuttosto complicata – a patto di cominciare a cambiare se stessi partendo dalle cose più semplici e concrete. Ad esempio cercando di stare nel mondo prendendone nel frattempo la giusta distanza. Governando in modo diverso faccende quotidiane e basilari come il dormire, il mangiare, il desiderio e il bisogno di riconoscimento, il silenzio con se stessi e l’incontro con gli altri. Sembrano bazzecole, ma quelli che vi si sono cimentati seriamente dicono che la sfida sia di vertiginosa difficoltà. E, soprattutto, pare duri tutta la vita.” Non a caso sono i certosini che con la loro vita al minimo lo attirano maggiormente. “E la capacità certosina di vivere apparentemente al minimo, in quella che dall’esterno viene percepita come un’esistenza ridotta alla semplicità più essenziale e al distacco più severo, risuona con forza sempre maggiore in un mondo prigioniero dei tanti idoli – dal successo, al denaro, dal sesso al potere – che incombono sulle nostre vite.”
Riemerge il vero problema. “Questo allenamento al governo di sé, delle proprie parole e dei propri gesti, dell’essere consapevoli e dello spazio nel quale si colloca e dell’uso che si sta facendo del tempo, proprio e altrui, porta a poco a poco a camminare su una sorta di crinale” i cui due versanti sono il silenzio e la separatezza.
Il monastero è separato dal resto del mondo da mura ma anche al suo interno il monaco vive, pur rimanendo all’interno di una comunità che non lo lascia mai solo, un reale e duraturo distacco dagli altri. La pratica del silenzio e la preghiera che ne sono conseguenza e presupposto gli fanno acquisire una profonda dimensione interiore e un rapporto privilegiato con Dio.
La separatezza, fatta di mura e di regole a cui attenersi, segna il limite oltre il quale non si può andare.
“Il senso del limite insegna a stare con naturalezza dentro la propria finitudine. È una pratica che richiede l’esercizio dell’attenzione verso gli altri.” Rimarca Boatti.
Sono due affermazioni pregne di sensatezza, queste, la cui strettissima relazione, purtroppo, sfugge a molti. Occorrerebbe rifletterci a lungo.
Prendere coscienza che la natura ha un limite significa riporsi con i piedi per terra. Buttare gli stupidi sogni infarciti di onnipotenza. Smetterla con la storia indegna di progressi infiniti tutto incentrati sull’avere e il possedere. Con le magnifiche sorti e progressive che, ormai, non dovrebbero più illudere nessuno.
Significa ricostruire un profondo e rispettoso legame con l’altro perché ridurre al minimo il nostro impatto ambientale restituirebbe lo spazio vitale agli altri che ne hanno diritto al pari di noi. Significa offrire una speranza di vita anche alle future generazioni che non sono lontane ma, nei nostri figli, sono già qui, al nostro fianco.
Ma prendere coscienza dei limiti che ci sono imposti dalla finitezza del mondo significa in concreto rivalutare all’infinito ogni nostro atto quotidiano. Significa riconoscere che il mondo in cui viviamo si crea o si cambia solo per quell’atto. Significa, però, anche chiederci se i monasteri sono stati davvero fuori dal mondo quando in realtà si sono per secoli cibati del lavoro di servi. Dei frutti di immensi feudi. E hanno basato la loro esistenza su un enorme potere.
Significa chiederci se sono davvero fuori dal mondo quando usano piatti di plastica come a Camaldoli o quando mangiano di tutto, sebbene in modo parco.
I più contenuti, i certosini, a mezzogiorno hanno un pasto ricco e sostanzioso “composto da un primo, un secondo di verdure con pesce, o formaggi o uova, mentre la carne è sempre esclusa dalla tavola della certosa.”
Ho il sospetto che l’essere parchi derivi più da una privazione individuale, come fosse una punizione a cui sottoporsi, che dalla consapevolezza che ciò rispetti i diritti dell’altro. E ho la certezza che da questo rispetto sfuggano del tutto le creature viventi e senzienti che ci accompagnano nel nostro percorso di vita, come se le atroci sofferenze a cui noi le costringiamo fossero dovute o normali. Ma ciò riguarda il cristianesimo che non ha ancora prodotto una seria riflessione su ciò che è il dolore e su ciò che è la compassione. Né, penso potrà produrla a breve, avendo assunto l’uomo a re del creato e a perfetta somiglianza di dio.
Sulle strade del silenzio è scritto bene e ci insegna molto. Forse ci dice poco dei molti monasteri d’Italia visitati e ancor meno dei loro spaesati dintorni. Forse ci parla di più dello spaesamento dell’autore e del suo affannoso bisogno di luce. Che però si nutre, di un girovagare continuo che alla fine può solo stancare – o produrre un ennesimo volume. E che non disdegna “una bella Coca Cola gelata” ingerita – a dispetto di un fragile corpo – fra splendidi e raffinati brani musicali.
È il contrario di quanto insegnano i parchi e stanziali monaci. Ma poco importa.
L’importante è leggere a pagina 42 che “O si è, insomma, quel che si dice di voler essere, o non lo si è. E allora è inutile fare del teatro o della rappresentazione per camuffare la situazione.”
