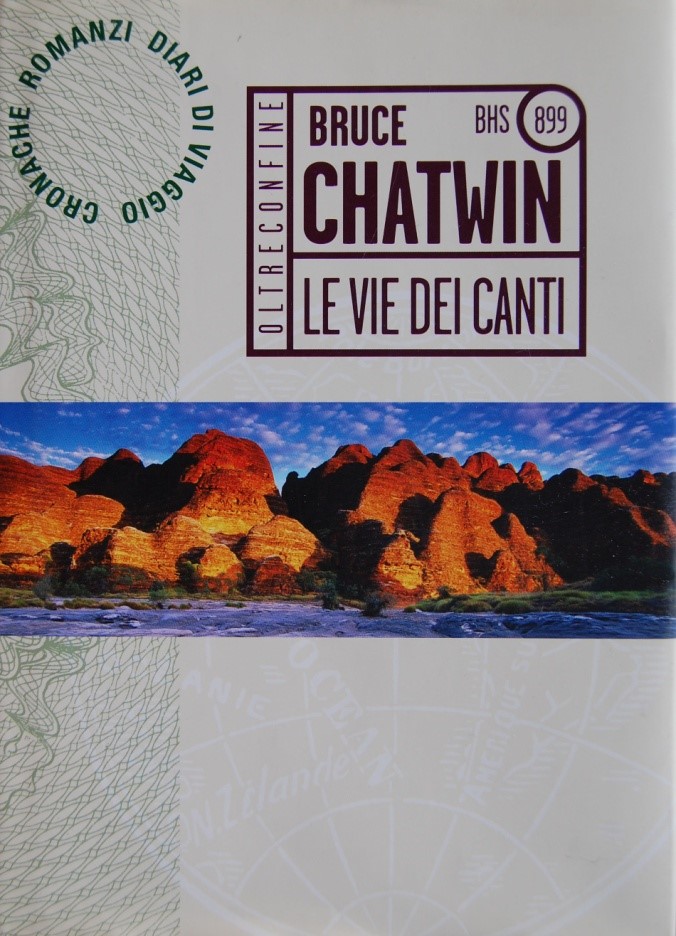
Fabbri Editori, 2006
Nel maggio del 2006, guidati dall’amico Alessandro Vergari, attraversammo a piedi il Taigeto, partendo da Sparta, con l’intenzione di percorrere verso sud l’affusolata penisola del Mani. Lungo la via passammo da Kardamili e decidemmo di andare a trovare l’anziano Patrick Leigh Fermor, uno dei più grandi camminatori del XX secolo. Ci sembrò doveroso, dal momento che stavamo ripercorrendo i sentieri che lui aveva tracciato negli anni trenta e descritto nel suo famoso libro Mani. Viaggi nel Peloponneso, edito da Adelphi nel 2004.
Parlando di lui e con lui, scoprii che Bruce Chatwin, suo grandissimo amico morto a Nizza il 18 gennaio 1989 a soli 49 anni, gli aveva chiesto di essere seppellito in una chiesetta nei pressi della sua splendida residenza. Quando, nei boschi che ricoprivano il pendio sovrastante l’incantevole baia di Kardamili, ci sembrò di averla trovata – mancava qualsiasi iscrizione che indicasse la presenza del corpo dello scrittore – ci emozionammo tutti.
Bruce Charles Chatwin è stato un grande viaggiatore e un grande scrittore. Ha percepito il nomadismo come elemento costitutivo dell’uomo e ha cercato di teorizzare questa sua intuizione in vari libri. Le vie dei canti è, forse, il più affascinante.
In un capitoletto di due pagine – In principio – viene raccontata la cosmogonia degli aborigeni australiani. All’inizio la Terra era buia e disseminata di buche profonde ai cui margini era ammonticchiata materia informe. Un giorno il Sole ebbe voglia di nascere, seguito la sera dalla Luna e dalle Stelle, e con i suoi raggi scaldò e animò quelle molli masse di materia. Erano gli antenati e dai loro corpi vivificati nacquero dei figli. Quando gli antenato aprirono gli occhi videro quegli esseri appena nati giocare attorno a loro. Ogni forma vivente è nata così: da un antenato dalle sembianze umane. Quando gli antenati si alzarono in piedi, si scrollarono il fango di dosso e iniziarono a camminare. All’inizio dissero “Io sono” e poi, ad ogni passo, diedero nome a tutto ciò che incontrarono. Percorsero tutta la terra cantando i nomi delle cose e intanto cacciavano, mangiavano, facevano all’amore. In ogni pista percorsa lasciarono una scia di canto. Alla fine si stancarono e lentamente tornarono alle loro buie dimore eterne.
Chatwin dedusse da storie come questa che l’uomo era nato dal e nel deserto e da qui, camminando, si era propagato per tutto il globo. Aveva imparato a sopravvivere in un ambiente difficile di cui occorreva conoscere ogni anfratto. La sorgente d’acqua può salvare la vita, qualche sparuto albero dona ombra e armi, i cespugli danno il fuoco e gli animali sfamano. L’uomo, agli inizi della sua storia, fu nomade. Ed è per questo che ancor oggi associamo la malattia alla sosta e al ristagno. E che, se si vuole star bene e liberarsi dall’ansia, occorre muoversi e spostarsi continuamente. Perfino il neonato ha bisogno di sentirsi ondeggiare nella culla per acquistare tranquillità: ricorda quando era trasportato sulla schiena o nel ventre della madre camminatrice.
È nel romanzo saggio che l’indagine di Chatwin trova forma ed espressione.
Egli ci porta in giro per l’Australia seguendo bianchi immigrati dall’Europa più o meno recentemente che vivono in solitudine estrema nei vastissimi spazi di quella bellissima, colorata terra. Ci racconta le loro vite mentre, protetti dal sole cocente o da violenti temporali in misere capanne con i tetti di lamiera, mangiano frettolosamente carne arrostita.
Grazie a loro incontra aborigeni che ricordano bene ogni loro luogo sacro: quelle vie che loro chiamano Orme degli antenati, o Via della Legge, conosciute dagli occidentali come Vie dei Canti o Piste dei sogni. E ne racconta qualcuna.
Un giorno gli venne indicata la collina dove riposa l’Antenato Lucertola. E un uomo vestito “in celeste si alzò e cominciò a mimare i viaggi dell’Antenato Lucertola. Il canto era la storia della lucertola e della sua bella e giovane moglie: dal nord dell’Australia erano arrivati a piedi al mare meridionale e lì un abitante del sud aveva sedotto la moglie e rispedito lui a casa con una sostituta.” “Naturalmente, mi disse, quello che avevamo visto non era il vero canto della Lucertola, ma un falso fronte, una scenetta recitata per i forestieri. Il canto vero avrebbe enumerato ogni pozzo a cui beveva l’Uomo Lucertola, ogni albero da cui tagliò una lancia, ogni caverna in cui dormì durante il suo lungo cammino.”
Chatwin scoprì che nei canti non sono quasi mai le parole ad indicare i luoghi del lungo tragitto. Pensò fosse l’andamento melodico, un certo fraseggio musicale e la combinazione delle note, a descrivere il terreno in ogni suo andamento e i movimenti dei piedi dell’antenato che ad esso adeguavano ritmo e velocità. Si spiegò così il perché un uomo di una tribù di un angolo qualsiasi dell’Australia, capisce sempre quale regione venga cantata quando ascolta un uomo di un’altra lontanissima tribù, sebbene la lingua parlata da quest’ultimo sia incomprensibile e molto diversa dalla sua.
Il nomade deve poter vagare. Le difficoltà della frontiera gli sono risparmiate perché ogni membro di una tribù conosce anche la lingua delle tribù vicine. E non possiede terra non conosce confini e recinzioni. Conosce solo la strada su cui si deve immettere se vuole sopravvivere. I bianchi che vogliono costruire ferrovie, strade e abitati, devono rispettare le loro leggi che sono sacre perché garantiscono la vita. Sono costretti, quindi, a deviare le loro linee tracciate a tavolino perché non è consentito loro attraversare una Via della Legge.
È affascinante il percorso di Chatwin. Ma il suo intento, che è quello di svelare “qual è la natura dell’inquietudine umana” ha bisogno anche di soste, magari frettolose e “prima che si [insinui] in me il malessere della sedentarietà”. Ha bisogno di riaprire i taccuini in cui aveva riportato idee, citazioni e incontri avuti nel corso degli anni. E allora il suo romanzo si fa, in parte, saggio. Cita Pascal, Baudelaire, Rimbaud, Kipling e molti altri autori. Riporta proverbi, favole, leggende e miti, raccolti fra i vari popoli che ha incontrato nel suo continuo vagabondare. Trascrive brani dai testi sacri e ci racconta cosmogonie in cui il Sole è femmina e la Luna maschio. Ricorda una conferenza di Arthur Koestler a cui ha partecipato con disappunto, e le discussioni sull’aggressività animale e umana nel chiuso dello studio di Konrad Zacharias Lorenz.
Fra antropologi e archeologi, stringendo fra le mani crani di Dinofelis – che lui intuisce essere l’archetipo della Bestia di cui l’uomo continua ad aver paura – e altri preziosi reperti conservati in prestigiosi musei, Chatwin elenca teorie e fa supposizioni ma non smette mai di raccontare con il tono leggero, appassionato e appassionante, del romanziere.
Può così non solo squarciare l’idea assurda che il mondo sia uniforme, cosa assai facile a farsi per tutti coloro che lo vogliono, nonostante il pensiero dominante e supposto unico che pervade e avvelena la civiltà Occidentale. Ma ci insinua nella mente il sospetto che l’altro abbia anche qualcosa di molto utile da insegnarci.
Come quando senza aggiungere commenti ci racconta la storia di una donna e di un bimbo che attendono il loro uomo andato via da tre giorni a trovare candele nuove per l’automobile guasta e lasciata ferma ai bordi di una polverosa strada, in un punto lontano da qualsiasi altro raggruppamento umano.
È una concezione del tempo e della vita diversa dalla nostra a trasparire. Più vicina ai ritmi naturali. Più consona alla vita.
Non per nulla Bruce Charles Chatwin può dire in una bella pagina di questo libro “La rinuncia può essere una soluzione anche di questi tempi”. E Arkady, il suo accompagnatore di origini russe, può rispondere “Forse hai ragione. Se il mondo ha un futuro, è in un futuro ascetico.”
