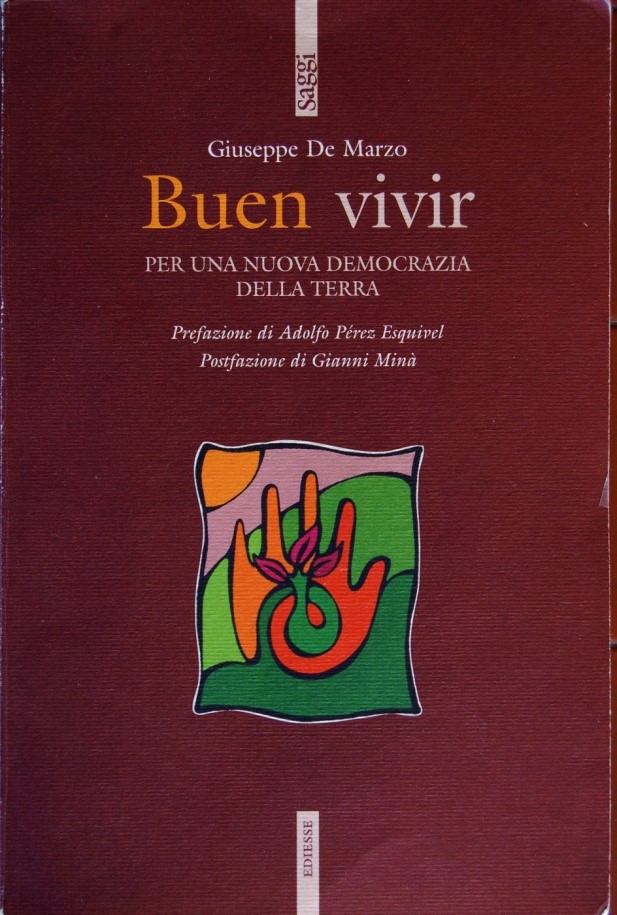
Per una nuova democrazia della Terra
Prefazione di Adolfo Pèrez Esquivel
Postfazione di Gianni Minà
Casa Editrice Ediesse, 2009
L’idea di modernità, fondata sulla credenza che solo uno sviluppo illimitato retto da una costante crescita economica sarà capace di soddisfare bisogni umani sempre maggiori, è un’enorme baggianata, come in molti ormai sanno, perché “non solo si blocca dinnanzi alla crisi ambientale e climatica, ma ne rappresenta la causa.” La crisi strutturale che stiamo vivendo, infatti, non è la solita crisi legata alla sovrapproduzione generata dai meccanismi di riproduzione del capitale: per la prima volta, dopo cinquecento anni di storia, costringe il sistema capitalista a fare i conti con i limiti del pianeta.
Nonostante ciò le ricette di vari organismi internazionali (FMI, BM, WTO), di potenti banche e complessi industriali multinazionali, dei governi delle potenze più importanti del globo, sono ripetute come mantra e imposte a qualunque nazione in difficoltà. Queste assurde indicazioni hanno definitivamente trasformato un’economia di mercato in una società di mercato e sono la causa prima non solo dell’acutizzarsi della crisi stessa, ma anche della precarietà in cui è costretta la vita sull’intero pianeta.
Cosa succederebbe, si chiede l’autore, se la sola Cina, “raggiungesse gli standard di consumo auspicati dal G8 e dalla BM”? La risposta è scontata. “avremmo bisogno di altri tre pianeti per sostenere l’impatto ambientale che questo genererebbe. Un punto che segna una strada di non ritorno ed evidenzia come il capitalismo, piaccia o no, sia completamente inadeguato a consentire l’uscita dalla crisi.”
Ma forse il problema non è questo. Forse quello che hanno in mente “lor signori” è un’altra cosa. Giuseppe De Marzo lo sa e, infatti, coglie nel segno quando sostiene che “vi è però un’altra ipotesi (…): il capitalismo può continuare a sopravvivere attraverso l’esclusione di quattro quinti dell’umanità dai benefici che esso genera.” Le conseguenze inumane e vergognose sono di fronte agli occhi di tutti. “Mantenere gli standard di consumo del 15/18% dell’umanità richiede il sacrificio della restante parte della popolazione planetaria. (…) risulta che il 50% della ricchezza planetaria appartiene al 2% della popolazione mondiale. (…) Dagli anni ’50 ad oggi la quantità di affamati è aumentata. (…) La popolazione che non accede al cibo è di quasi un miliardo di esseri umani, cioè di una persona ogni sei che popola la Terra. (…) Ogni giorno trentacinquemila bambini muoiono di fame.”
Se la situazione è questa e se la società di mercato ci ha colonizzato la mente, come potremmo uscirne?
L’autore utilizza vari strumenti, dall’ecologismo dei poveri, alla sociologia dell’assenza, dall’economia ecologica alla scienza postnormale, tutti collegati al concetto fondamentale di metabolismo sociale. Questo approccio, multidisciplinare e multicriteriale, ha consentito l’individuazione di nuovi indicatori, come l’AHPPN che “rappresenta la misura dell’appropriazione umana della produzione primaria netta”; o l’impronta ecologica introdotta da Mathis Wackernagel nel 1996, “che nel 2003 ha dato vita alla Rete globale dell’impronta ecologica”. O ancora, l’indice elaborato dall’Istituto Wuppertal in Germania nel 1994, che serve a “misurare gli input di materiale per unità di servizio, cercando di concentrarsi sullo studio “a monte” e non “a valle” degli impatti della produzione.”
Si scopre così che la nostra economia non è per nulla dematerializzata come si vorrebbe far credere. E che il bisogno di risorse depreda e impoverisce senza tregua luoghi e popoli nei paesi del cosiddetto terzo mondo a tal punto da generare nei loro confronti un debito ecologico enorme e ben più alto dei crediti che i paesi ricchi esigono. Si scopre che il fantomatico aumento della ricchezza di cui vantano nazioni e imprese del mondo Occidentale è solo frutto di un’esternalizzazione dei costi ambientali che sta distruggendo l’intero pianeta.
E ancora si scopre che questo malsano sviluppo ha generato città globali divoratrici di energia, sempre più invivibili, insostenibili e instabili.
In positivo, però, si scopre anche che le città “rappresentano lo spazio politico molto di più di quanto lo sia oggi lo Stato.” Che in esse “nascono … resistenze, lotte e rivendicazioni nuove portate avanti da soggetti non formali che grazie proprio a pratiche non istituzionalizzate stanno sviluppando forme di autogoverno e di democrazia fortemente innovative ed efficaci.” E che ciò è la risposta politica alla “rottura nella relazione tra le forze classiche della politica e la società civile”. Rottura causata dall’incapacità delle forze politiche tradizionali, anche e in special modo di quelle progressiste, a capire i danni causati dalle politiche economiche volute dai tecnocrati del FMI, della BM, del WTO o delle agenzie a loro collegate e delle multinazionali, che dettano legge al di là e contro ogni regola democratica.
In parallelo si sta producendo “un’esacerbazione ulteriore del conflitto sociale nei luoghi in cui il capitale deve appropriarsi di risorse, materie prime, materiale genetico, spazi bioriproduttivi, atmosfera e quant’altro possa essere necessario per continuare il [suo] processo di accumulazione e di riproduzione”. Ed è proprio in questi luoghi che stanno sviluppandosi concretamente risposte significative alla crisi in cui l’umanità si è cacciata. “I contadini e le comunità indigene si sono trasformati per necessità nei movimenti tra i più significativi a livello locale e internazionale”, specialmente nell’America Meridionale.
“I movimenti indigeni latinoamericani sono in tal senso un esempio emblematico di un “approccio universale” (…) Non si accontentano e non partono esclusivamente dalle loro lotte e resistenze, ma riescono sempre ad utilizzare un linguaggio e una narrazione che offre un approccio interdipendente e complessivo del problema. Cercano di parlare a tutti e tutte in un perimetro più ampio della singola rivendicazione particolare di un territorio o di una comunità. Costruiscono alleanze, criticano il modello di sviluppo nel suo complesso, propongono soluzioni globali e costruiscono reti fondate su un forte sentimento di giustizia sociale ed ambientale.”
Lottano per una territorializzazione delle relazioni sociali ed hanno capito che è “la comunità e non la città il luogo in cui sviluppare la reciprocità, la complementarietà, la solidarietà, la spiritualità e la giustizia dei popoli originari.” Hanno ottenuto, in Ecuador nell’ottobre del 2008 e in Bolivia nel febbraio del 2009, delle Costituzioni in cui per la prima volta nella storia dell’umanità, sono riconosciuti i diritti della natura, che anzi vengono assunti “come un nuovo paradigma di civiltà.”
Questi movimenti hanno affossato definitivamente l’attitudine avanguardista che ha fisiologicamente guidato coloro che hanno finora espresso alterità rispetto il modello capitalista. Hanno capito che la loro “forza maggiore sta proprio nella capacità di non essere centro ma luogo che contiene tanti luoghi.” E con ciò stanno rifondando la democrazia. “Democrazia che si vuole declinata a partire dalla “plurinazionalità”, dalla “interculturalità”, dal buen vivir e dai “diritti della natura”, come pilastri fondanti di un nuovo paradigma di civiltà”.
L’economista cileno Manfred Max-Neef “sostiene che nel corso del tempo e per tutti gli umani le necessità sono state sempre le stesse e che quello che muta è in realtà la maniera di soddisfarle. Bisogni umani intesi come interdipendenti e finiti, invece che infiniti e ordinati gerarchicamente. (…) Max-Neef classifica nove esigenze fondamentali della persona umana: sussistenza, protezione, affetto, comprensione, partecipazione, tempo libero, creazione, identità, libertà. Vi è persino un decimo bisogno alla studio attualmente: la trascendenza. (…) Vi sono interazione e complementarietà tra i bisogni, ma non sostituzione. Non è quindi il tipo di materiale o di energia a dare soddisfazione, ma la misura in cui i bisogni vengono soddisfatti. Questo significa che è possibile avere più soddisfazione anche con minor utilizzo di materiale e di energia.”
È quindi possibile costruire una nuovo paradigma di civiltà, una nuova idea di sviluppo, che molto spesso coincide con il sumak kawsay, o il suma qamaña, o il buen vivir di molte comunità native. “Un paradigma che parta dall’esigenza profonda e urgente di congiungere lo sviluppo con due indispensabili compagni di viaggio: la giustizia ambientale e la giustizia sociale.” E che si fonda su “un pensiero che avvicina uomini e donne a tutti gli altri esseri viventi, ne individua i nessi biologici e spirituali, attribuisce responsabilità collettive ampie e destituisce l’uomo œconomicus dal ruolo di utilizzatore e dominatore unico dei cicli della vita sul pianeta, restituendogli il prestigioso incarico di “amministratore” della casa comune.”
Ha ragione Giuseppe De Marzo, economista e portavoce dell’associazione A Sud, a sostenere che la sociologia degli esclusi ci insegna altro, rispetto ciò che il capitalismo con il suo “pensiero unico” è andato sostenendo. Ci insegna che ci sono forze e movimenti, idee e pratiche che a loro modo stanno sperimentando vie nuove per uscire dalla crisi. Ma a mio parere il problema centrale è un altro. Resta sempre quello legato alla mancanza di coscienza o alla colonizzazione delle menti, diffusa in Occidente. Fino a quando permarrà, quei popoli innovatori, quelle comunità in cammino, saranno in pericolo. Fino a quando in Occidente non si acquisirà il senso del limite e con questo un minimo di umanità, quelle culture saranno in pericolo. Le loro costituzioni verranno stracciate come del resto, lo sono le nostre. Le loro sperimentazioni e i loro modi del vivere saranno giudicati anacronistici come lo furono sempre in passato.
È lo stile di vita di chi è più forte e si immagina più ricco e più civile a dover cambiare. Perché crea un uomo pericoloso e ingordo, un suddito cieco e amorale, capace si generare ingiustizie, guerre e distruzione ambientale in tutto il pianeta.
Ma come giungere ad una trasformazione sociale, a quel fermento sociale capace, come dice De Marzio di “trasformare società e movimenti in società e comunità in movimento”?
Forse a partire dalla considerazione che il problema non è solo culturale.
Non è affatto vero, come sostiene Adolfo Pèrez Esquivel nella prefazione di questo per altro utilissimo volume che “la dominazione non inizia dall’economico ma dal culturale” e che “l’educazione … e l’informazione sono strumenti di formazione per far sorgere valori”.
Noi siamo molto educati e molto informati. Eppure affamiamo il mondo. Eppure distruggiamo risorse. Eppure stiamo uccidendo il futuro dei nostri stessi figli.
Siamo tanto informati da irridere e scartare a priori ciò che di nuovo e di vitale ci giunge dai nostri fratelli poveri: il progresso non si ferma, sosteniamo tronfi.
Siamo tanto educati da non osare chiamare coglioni coloro che, ambientalisti e amanti della natura, mangiano carne; coloro che, pur professandosi rivoluzionari e vogliosi di un repentino cambiamento del mondo, sono poi incapaci a cambiare qualsiasi minima loro abitudine di vita. Coloro che invocano più lavoro, più prodotti, più merci, senza mai chiedersi che ce ne faremo degli scarti, a chi venderemo merci sempre più inutili e sempre meno durevoli, dove prenderemo le materie prime e l’energia necessaria a produrle.
Mi vengono in mente gli idioti che sostengono che l’uomo è onnivoro, dimenticando che è anche razionale e che ciò significa potere e sapere scegliere la cosa migliore. O chi ha santificato il lavoro salariato creatore di merci e di rapporti umani cosalizzati, dimenticando che la vita e la libertà è sempre altrove.
Ecco sono le nostre azioni quotidiane, la nostra pratica quotidiana, più che il nostro pensiero, a fare il mondo. Vale più una disubbidienza a un cliché, una ribellione ad una tradizione, che satollarsi la coscienza di belle cose per poi chinare il capo senza provare vergogna o indignazione di fronte ad un’ingiustizia. L’ingiustizia è una pratica come è molto attinente alla pratica chi muore di fame. Più che belle teorie infarcite di altrettanto belle parole coloro che soffrono e che muoiono hanno bisogno di trovare in noi pratiche di vita degne, rispettose di loro e della natura.
Giuseppe De Marzio sostiene che “il capitalismo ha immaginato e quindi realizzato, una separazione tra esseri umani e vita, cultura e natura, maschile e femminile, producendo un’umanità malata”. Ma il capitalismo non ha immaginato proprio niente!
Il mondo è quel che è perché noi facciamo tutti i giorni quel che facciamo.
Forse le nostre speranze sono riposte tutte qui: nella capacità che avremo di collegare ogni piccola azione alla globalità della vita. Nel senso che sapremo dare alla nostra quotidianità. Nel vivere ogni fatto culturale come essenzialmente pratico. Nel non separare mai la cultura e la conoscenza dalla pratica.
Penso che più che i diritti dell’uomo vecchi ormai di qualche centinaio di anni o i giovani diritti della natura sanciti nelle varie carte, sarà la pratica di un modello insostenibile che o ci ucciderà o ci costringerà doloranti a tornare finalmente con i piedi per terra. Nel frattempo e prima che tutto crolli, quanti saranno coloro che, intelligenti, acculturati, umani, civili ed educati sapranno osare e richiedere nuove regole, sapranno incamminarsi su strade nuove?
Quanti sapranno esigere da se stessi un minimo di coerenza?
